L'analisi
Mediterraneo sempre più caldo, così trasforma le ondate di calore in killer silenziosi. Il clima che cambia e stravolge l'Europa

Il nostro mare Mediterraneo è sempre più caldo
L'ondata di calore di giugno che ha interessato il territorio europeo è stata resa più intensa dalle temperature insolitamente alte del Mediterraneo. Gran parte dell’Europa occidentale ha registrato temperature superiori di 2,8°C rispetto alla media dello stesso mese (calcolata sul periodo 1991-2020). Il Mediterraneo è infatti un elemento cruciale del sistema climatico in grado di influenzare fortemente le temperature europee, con un impatto destinato ad aumentare. Il riscaldamento di questo mare è infatti più veloce della media globale: le sue temperature superficiali stanno aumentando di 0,4°C ogni 10 anni a partire dagli anni ’80, ovvero il 20 per cento più velocemente rispetto alla media. Questo aumento rende più probabili picchi eccezionalmente alti delle temperature: lungo le coste francesi e spagnole a giugno si sono registrati valori superiori alla media di 4°C.
Le ondate di calore, ovvero periodi di diversi giorni in cui le temperature atmosferiche sono molto elevate, diventano più probabili e più intense con il riscaldamento globale. Il calcolo si basa sui valori della temperatura nel periodo preindustriale (1850-1900), cioè quando le emissioni di gas serra non erano presenti in misura apprezzabile tale da alterare il clima. Rispetto a questa base, le temperature globali sono aumentate in media di 1,3°C. Nonostante ciò, attribuire ad uno specifico evento estremo, come la recente ondata di calore, il ruolo del cambiamento climatico non è un’impresa semplice. Per questo motivo, da oltre un decennio, la World Weather Attribution – una collaborazione accademica tra varie università e centri di ricerca – cerca di risolvere questa questione.
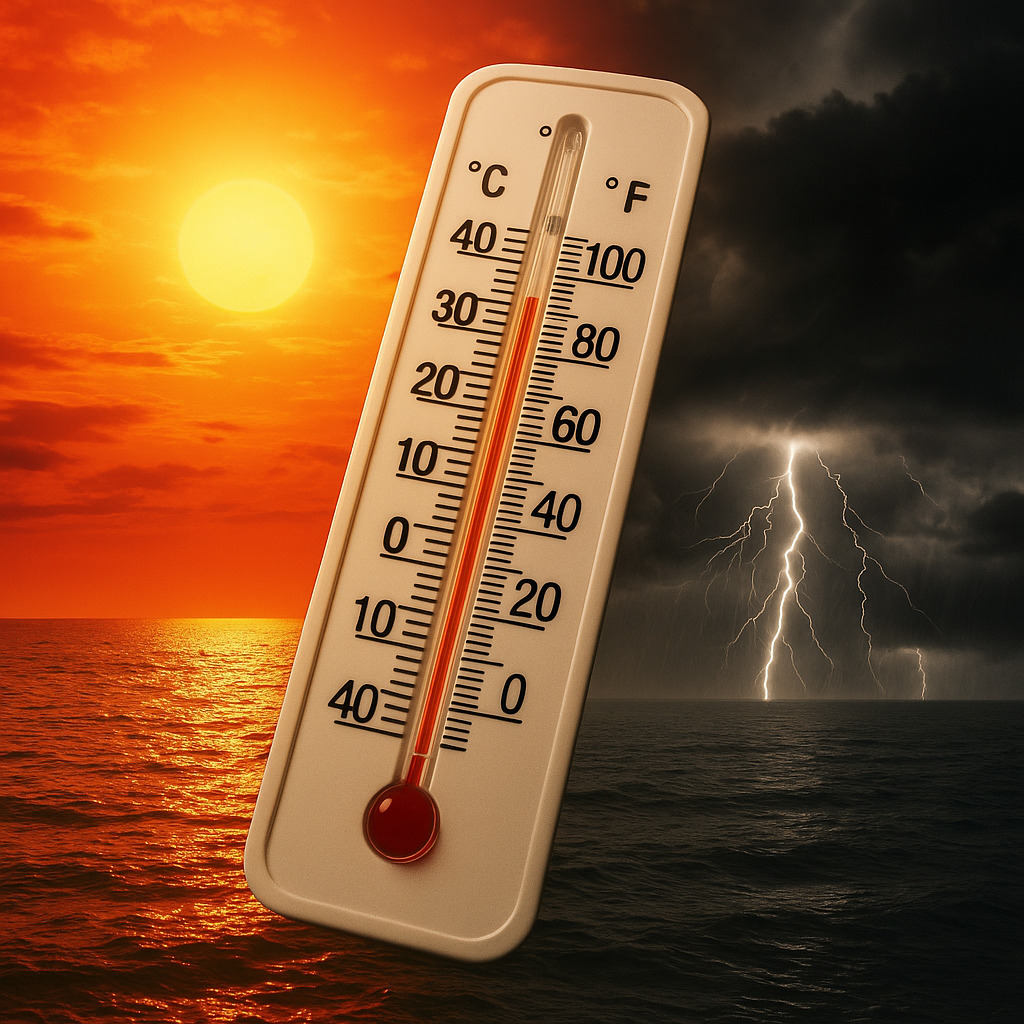
Il nostro mare è sempre più caldo, il cambiamento climatico si fa sentire ogni anno di più
Il metodo utilizzato per valutare se il cambiamento climatico abbia avuto un ruolo determinante nel verificarsi di un certo evento meteorologico estremo inizia con definire con precisione il contesto: dal numero di persone coinvolte all’entità dei danni, dalla regione geografica alla durata. Dopodiché viene calcolato quanto tempo, in media, passa tra due eventi simili: il cosiddetto tempo di ritorno. Infine, vengono fatte delle simulazioni confrontando i modelli con la temperatura attuale e con i valori preindustriali, per valutare quanto il riscaldamento globale abbia accorciato il tempo di ritorno: cioè se l’evento fa parte della variabilità climatica naturale, oppure se è stato reso più probabile dalle alte temperature. In questo modo è possibile stabilire se il cambiamento climatico abbia reso un preciso fenomeno meteorologico estremo più probabile o più intenso.
Lo stesso approccio è stato usato per studiare la recente ondata di calore, limitando però l’analisi al solo Regno Unito, per motivi pratici. Nella regione considerata è emerso che attualmente eventi di questo tipo si verificano in media con frequenza di uno ogni 5 anni, mentre nei modelli senza il riscaldamento globale la frequenza scende a uno ogni 50. Dai risultati dell’analisi si vede quindi che il cambiamento climatico ha aumentato la probabilità del verificarsi di questo preciso fenomeno. Una volta stabilito questo, è stato possibile anche valutare il numero di decessi in eccesso causati dal caldo: da uno studio effettuato dal Grantham Institute di Londra è emerso infatti che, in 10 giorni, il recente evento ha causato un aumento di circa 1.200 decessi in 12 città europee. Milano è stata la città più interessata con circa 317 morti in eccesso, seguita da Barcellona con 286 e Parigi con 235.
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy









